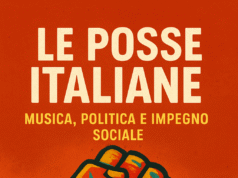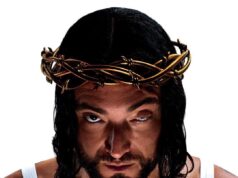“La violenza verbale nei testi dei rapper italiani”: analisi linguistica e letteraria di Giovanni Salonia è un libro che prova a fare luce sulla polemica celata nella dicotomia rap/trap italiana e violenza.
Il libro, attraverso un’attenta analisi linguistica e letteraria, mette in evidenza vari aspetti, con la consapevolezza di poter trovare degli elementi necessari in grado di creare un dibattito costruttivo. Il libro, edito da Il Viandante, viene raccontato così:
“Il volume affronta, come può intuirsi dal titolo, la questione della violenza verbale nelle canzoni dei rapper, e lo fa a partire da una prospettiva linguistico-letteraria e, indirettamente, anche pedagogica. Gli artisti “violenti” rappresentano un pericolo per le nuove generazioni? Sarebbe necessario intervenire censurando?
Ecco, queste sono solo alcune delle domande a cui l’autore prova a dare una risposta, argomentando tutto con l’ausilio di una bibliografia ricca e accuratamente selezionata”.
Ho avuto il piacere di intervistare Salonia, per approfondire tutta una serie di tematiche legate al libro e ne è venuto fuori un confronto davvero intrigante.

Intervista all’autore del Libro Giovanni Salonia
Ciao Salonia, benvenuto, grazie e complimenti per questo lavoro prezioso che mi ha offerto tantissimi spunti di riflessione! “La violenza verbale nei testi dei rapper italiani: analisi linguistica e letteraria” è il tuo nuovo libro. Innanzitutto ti chiedo per quale motivo hai avvertito l’esigenza di esprimerti in tal senso, e cosa speri di trasmettere ai tuoi lettori?
Questo libro nasce come tesi di laurea, e la scelta è ricaduta sul tema in maniera quasi “fisiologica”: da amante del genere stanco di sentire discorsi criminalizzanti privi di ogni riflessione, ho provato a costruire delle argomentazioni che potessero problematizzare e ricontestualizzare la violenza presente nelle canzoni, producendo nuovi spunti di riflessione.
Un punto focale del libro è che il rap – così come la trap – sono lo specchio della società. Un artista che si accontenta semplicemente di raccontare e rappresentare ciò che lo circonda, non finisce per omologarsi?
Se un artista sceglie di dar voce al suo disagio personale, la sua arte sarà sincera, e se quel disagio è stato già raccontato da altri, è una voce in più a testimoniare. A quel punto, comunque, interviene la forma artistica a creare l’innovazione.
Mr. Simpatia è un progetto chiave nella prima parte del libro. Il fatto che questo album sia stato estrapolato in un contesto underground, e concepito per una nicchia, lo differenzia dagli altri esempi proposti, caratterizzati da prodotti maggiormente esposti?
L’averlo concepito per una nicchia portò probabilmente Fabri Fibra a calcare ulteriormente la mano, a dare sfogo in maniera sfrenata e disinibita a quei mostri che si portava dentro. In questo forse si differenziava da altri progetti. Il processo di ascolto-lettura segue però delle traiettorie sempre simili e dipende dal pubblico più che dall’autore in sé. Il disco di Fibra ebbe infatti una risonanza popolare inaspettata.
In un passaggio del libro si afferma che la prima Dark Polo Gang è stata involontariamente geniale, e andrebbe trattata come una sorta di bambinoni che giocano a fare i delinquenti. Non è una riflessione troppo tesa a giustificare la pochezza lirica e creativa del gruppo?
Ci tengo a dire una cosa: io nel libro non ho voluto “difendere” nessuno. La DPG è stata fondamentale nel lancio della trap in Italia, e il grande successo riscosso — artistico e mediatico — ha un significato generazionale profondo. Prima di stigmatizzare dobbiamo chiederci il perché del successo di un progetto del genere.
Sono completamente d’accordo sul discorso riguardante la censura, e il suo non poter mai rappresentare una soluzione. L’esagerazione ostentata dai rapper, quanto può essere effettivamente efficace nei confronti della censura?
Il fatto che un rapper ostenti o esageri non implica che vada censurato, ed è proprio questo il nodo: non si può censurare qualcosa solo perché ci infastidisce. Bisogna sempre problematizzare e decostruire, specie quando a produrre certa musica sono ragazzi o ragazzini.
Gli artisti dichiarano di non essere responsabili di ciò che affermano nelle canzoni. Allo stesso tempo, raramente accettano chi critica un certo modus operandi eccessivamente maschilista. Perché i rapper si sentono in dovere di poter dire tutto quello che vogliono, ma spesso non sono disposti a tollerare una visione differente?
Chiunque non accetti il confronto democratico va senz’altro stigmatizzato, ma bisogna capire in quale contesto vengono mosse determinate critiche: nel terzo capitolo parlo di certi programmi televisivi in cui uomini delle istituzioni o dei media si lanciano all’assedio del rapper di turno, muovendogli contro accuse in maniera molto aggressiva. Ecco, questo non è utile a nutrire un dibattito democratico. In ogni caso, ci tengo a specificarlo, il rapper “delinquente” può essere stigmatizzato eticamente in quanto “delinquente” ma ciò non implica che la sua produzione debba essere squalificata in automatico, sono due piani di lettura diversi.
Secondo lei, che ruolo svolgono le etichette discografiche rispetto ai temi trattati dai rapper? L’industria può influenzare i rapper?
Probabilmente il ruolo delle etichette è più insidioso. Qualche giorno fa, rispondendo a una mia domanda, Tormento mi disse che la paura vende. Le etichette investono su questa musica perché piace e spingono affinché venga prodotta. In poche parole, provano a monetizzare la “paura”. A quel punto sta all’ascoltatore riconoscere l’arte che proviene dal disagio e il semplice intrattenimento macabro (che ha comunque il suo senso).
Facciamo un focus sul pubblico. Gli ascoltatori della trap italiana, sono perlopiù adolescenti o giovani italiani. Il fatto stesso che questo bacino d’utenza consideri ribelli determinati prodotti – a discapito ad esempio della poetica di un Pasolini, o del cinema di Kubrick – deriva da una totale mancanza di ricerca, oppure è una scelta ponderata? Il pubblico che sceglie di ascoltare la trap, ha una cultura – musicale e non – solida allo spalle?
Arrivare a Pasolini e a Kubrick — ed eventualmente criticarli — richiede degli strumenti che chi stigmatizza la trap spesso non ha. Quella rappresentata dalla canzone è una forma immediatamente accessibile, e ciò rende il processo di accusa molto più semplice. La letteratura e il cinema, inoltre, palesano in maniera chiara la loro finzionalità, mentre nel rap il confine realtà/finzione è molto più sfumato.
Ho trovato molto interessante il suo soffermarsi sulla strage di Corinaldo. Imputare ai trapper una tragedia simile, è sintomo di ignoranza. Un certo tipo di potere, condiziona i media in maniera irreversibile?
Il rap è sempre stato un modo per contestare i centri del potere. Come prodotto artistico-culturale, anche Sfera Ebbasta — pur non essendo apertamente rivoluzionario in termini politici — mette in crisi la narrativa conservatrice. Quindi sì, un certo tipo di potere condiziona irreversibilmente i media, è inevitabile.
Da scrittore, gestore di un ufficio stampa, e proprietario di una pagina che si occupa di rap italiano, come valuta la critica musicale nostrana, riferita al rap game?
Mi dispiace dire che la critica musicale italiana fondamentalmente non esiste e se si pensa a qualche nome “riconosciuto” si parla di persone molto adulte, che per una questione generazionale sono legate a un modo di percepire la musica lontano dall’attualità. Anche nel giornalismo bisogna dare spazio alle nuove penne.
È vero, ascoltare una canzone con tematiche misogine, non ti porta poi a stuprare una donna, così come giocare a GTA, non ti fa davvero ammazzare la gente. Però, è anche vero che il subconscio dell’essere umano, si lascia influenzare molto facilmente, ed assorbe come una spugna, specie dai 7 ai 22 anni. Come trovare un equilibrio tra queste due realtà?
Non è un problema che può porsi chi produce arte. Il contraltare deve essere l’educazione, l’unica vera e propria strategia di “difesa”.